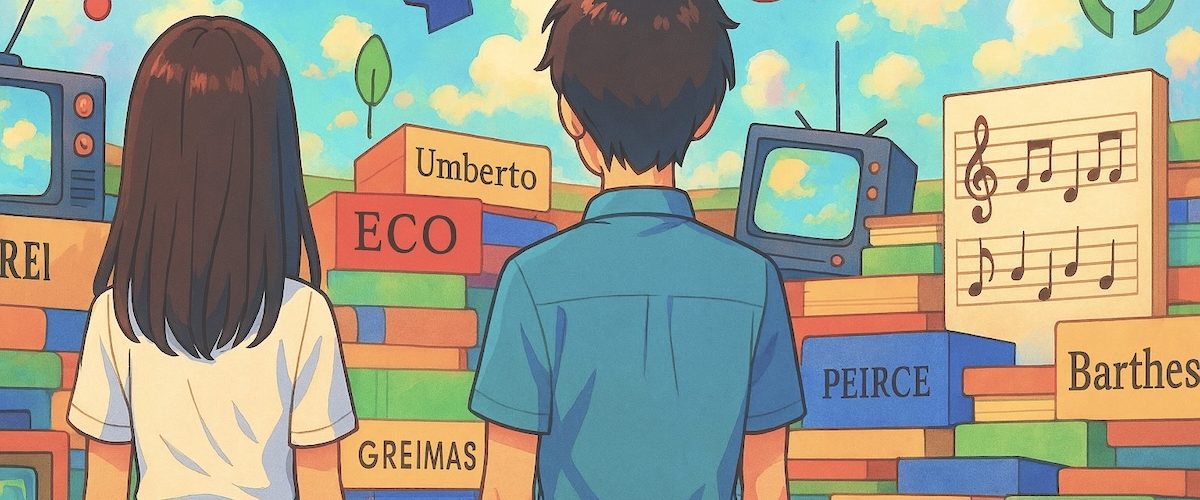Saussure osservava che la parola “arbitrarietà” poteva dare adito a malintesi. Secondo lui, non bisognava intendere che il significante fosse frutto della “libera scelta” del parlante, poiché l’individuo non aveva il potere di modificare un segno già stabilito all’interno di una comunità linguistica. Con quella parola, intendeva piuttosto dire che il significante è “immotivato”, ossia “arbitrario” rispetto al significato, poiché tra i due non esiste alcun legame naturale.
Egli concludeva il ragionamento segnalando due possibili obiezioni al principio dell’“arbitrarietà”.
La prima riguardava le “onomatopee”, che avrebbero potuto far pensare che la scelta del significante non fosse sempre arbitraria. Tuttavia, Saussure sosteneva che esse non facevano parte in modo organico di un sistema linguistico e che, in realtà, erano molto meno numerose di quanto si potesse credere. Alcune parole francesi potevano sembrare dotate di una sonorità suggestiva, ma, secondo lui, era sufficiente risalire alla loro origine latina per comprendere che in origine non erano “onomatopeiche”: la qualità sonora che si percepiva era solo il risultato casuale dell’evoluzione fonetica.
Quanto alle “onomatopee autentiche”, sottolineava che non solo erano poche, ma che la loro stessa formazione implicava già un certo grado di arbitrarietà, dal momento che si trattava di imitazioni solo approssimative — e già parzialmente convenzionali — di determinati suoni. Citava come esempio la differenza tra “ouaoua” in francese e “wau-wau” in tedesco. Inoltre, una volta entrate nel sistema linguistico, anche queste parole venivano sottoposte ai processi di trasformazione fonetica e morfologica comuni a tutte le altre, il che dimostrava, secondo lui, che avevano perso parte del loro carattere originario e acquisito quello tipico del “segno linguistico”, ovvero “immotivato”.
La seconda obiezione concerneva le “esclamazioni”, le quali, essendo molto simili alle onomatopee, suscitavano osservazioni analoghe e, a suo avviso, non rappresentavano una seria minaccia alla sua tesi. Faceva notare che si era portati a considerarle come espressioni “spontanee” della realtà, suggerite in modo naturale, ma sosteneva che per la maggior parte di esse non esistesse un legame necessario tra significante e significato. Per dimostrarlo, invitava a confrontare due lingue diverse e osservare come queste espressioni potessero variare: ad esempio, al francese “aie”corrispondeva il tedesco “au”.
In sintesi, Saussure concludeva che “onomatopee” ed “esclamazioni” rivestivano un ruolo secondario e che la loro origine “simbolica” era in parte discutibile.