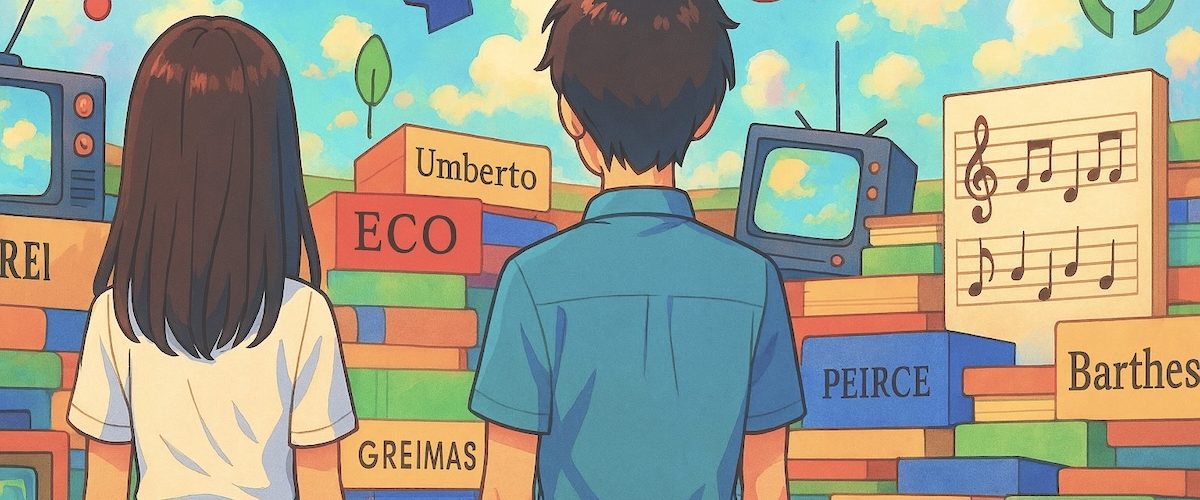“Secondo Peirce tutto il pensiero può essere concepito come segno, perché la vita è semiosi: un’ininterrotta produzione di segni, che nascono sulla base di saperi pregressi (a loro volta fatti di segni) e danno adito a una fuga illimitata di interpretazioni – interpretazioni che in certi momenti, o in certi contesti, si fissano in abitudini interpretative, convenzioni, codici, stereotipi, che poi entrano di nuovo nel circolo della semiosi, potenzialmente sempre disponibili a nuove declinazioni.” (Anna Maria Lorusso. Semiotica. Raffaello Cortina Editore)
Per Peirce, tutto il pensiero è quindi fatto di segni, un continuo processo di produzione e interpretazione di segni. Ogni nuovo segno nasce da conoscenze precedenti (che sono anch’esse segni) e genera nuove interpretazioni, in un flusso potenzialmente infinito. A volte, però, queste interpretazioni si stabilizzano in forme condivise come abitudini, codici, stereotipi o convenzioni, che a loro volta rientrano nel ciclo della semiosi, pronti a essere reinterpretati.
In questa visione, il segno è sempre un rimando: rappresenta qualcos’altro, da un certo punto di vista, in base a un criterio specifico. Ogni segno evidenzia solo alcuni aspetti dell’oggetto che rappresenta, lasciandone fuori altri. Il segno implica quindi tre elementi: qualcosa che rappresenta, ciò che viene rappresentato, e un pensiero che lo interpreta.
In questo senso, qualsiasi cosa può diventare un segno, se in certe condizioni assume una funzione rappresentativa. “Il carattere segnico è una funzione che, a certe condizioni, qualunque cosa può assumere. Il concetto di “libertà”, per esempio, può essere pensato come un segno se sta, per la mia mente, al posto di una catena di pensieri, sotto qualche rispetto – per esempio limitatamente alla riflessione sulla libertà di alcuni prigionieri di guerra.“ (Anna Maria Lorusso)