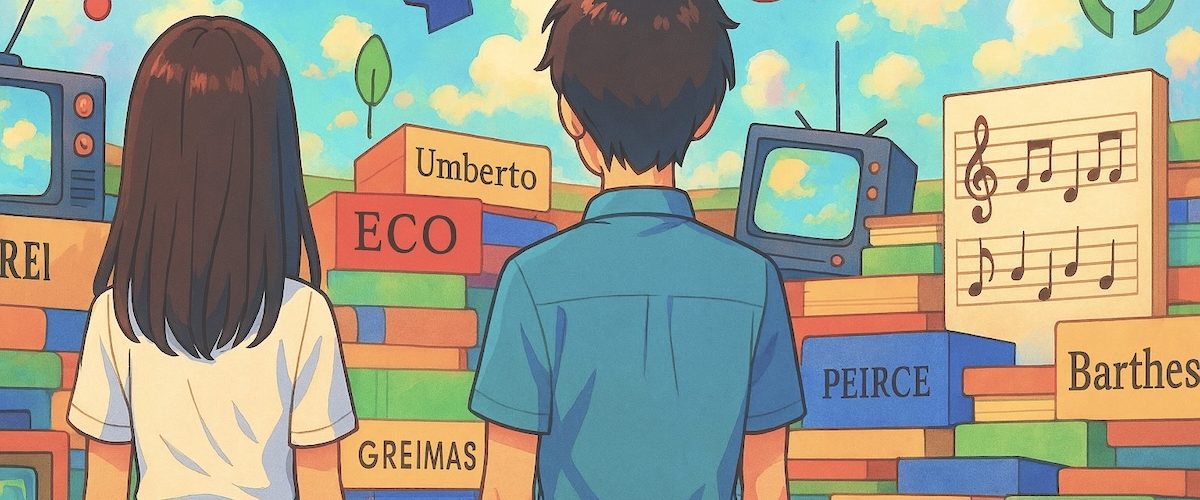Il segno linguistico possiede due caratteri primordiali. Il primo è l’arbitrarietà del segno.
Saussure sosteneva che il legame tra significante e significato fosse arbitrario. Dal momento che per lui il segno linguistico era il risultato dell’associazione tra un significante e un significato, affermava in modo più diretto che il segno stesso fosse arbitrario. Portava come esempio il fatto che l’idea di “sorella” non avesse alcun legame interno con la sequenza sonora s-o-r che in francese la rappresentava, e che avrebbe potuto benissimo essere espressa con una qualsiasi altra combinazione di suoni. A conferma di ciò citava le differenze esistenti tra le lingue, sottolineando che, ad esempio, il significato “bue” corrispondeva al significante b-o-euf in francese e a o-k-s (Ochs) in tedesco.
A suo dire, nessuno metteva in discussione il principio dell’arbitrarietà del segno, ma, aggiungeva “ma, spesso, è più facile scoprire una verità che assegnarle il posto che le spetta“.
Riteneva infatti che questo principio fosse fondamentale e dominasse tutta “la linguistica della lingua”, anche se le sue implicazioni non si rivelavano tutte con la stessa immediatezza: alcune venivano comprese solo dopo lunghi approfondimenti, e con esse si riconosceva l’importanza primaria del principio stesso.
Faceva inoltre un’osservazione che il linguista definisce “marginale“:
una volta che la semiologia fosse diventata una disciplina strutturata, avrebbe dovuto interrogarsi sul ruolo dei modi d’espressione basati su segni interamente naturali, come la pantomima, chiedendosi se fosse legittimo includerli nel proprio campo di studio. A suo avviso, anche qualora si decidesse di accoglierli, il centro dell’attenzione della semiologia avrebbe comunque dovuto restare sui sistemi fondati sull’arbitrarietà del segno.
Sottolineava che ogni forma d’espressione trasmessa all’interno di una società si basava in fondo su un’abitudine collettiva, ossia su una convenzione. Anche i segni di cortesia, che talvolta presentavano una certa espressività naturale — come il gesto del cinese che si prostrava nove volte davanti all’imperatore — non erano usati per il loro valore intrinseco, ma perché imposti da una regola.
Secondo Saussure, proprio i segni completamente arbitrari incarnavano meglio di altri l’ideale del “procedimento semiologico“. Per questo motivo, concludeva che la lingua, in quanto sistema espressivo più articolato e diffuso, rappresentava anche quello più emblematico. In tale prospettiva, riteneva che la linguistica potesse fungere da modello generale per l’intera semiologia, pur essendo la lingua solo uno dei tanti sistemi possibili.