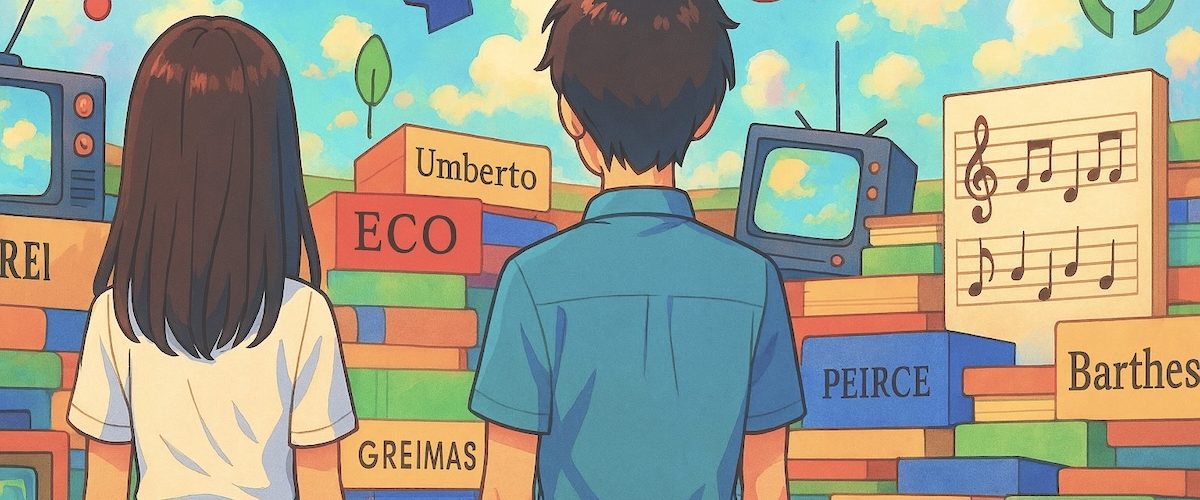Hjelmslev critica la “vecchia tradizione” seconda la quale segno è soprattutto “segno di qualcosa”. Questa concezione, osserva il linguista danese, pur essendo popolare e “largamente diffusa tra epistemologi e logici” è tuttavia “linguisticamente insostenibile”. Secondo Hjelmslev, il segno quindi non rimanda a “un contenuto esterno al segno stesso”, ma è invece (come già sostenuto da Saussurre, parlando di significante e significato) una entità “generata dalla connessione fra un’espressione e un contenuto”, connessione a cui Hjelmslev attribuisce un nome specifico: funzione segnica.
Se Ferdinand de Saussurre è il primo a concepire il segno linguistico come entità a due facce (il significante e il significato) unite da un legame di tipo arbitrario, “Hjelmslev riprende questi presupposti e li sviluppa, non parlando più di due facce del segno (significante e significato) ma di due piani del linguaggio: espressione e contenuto. Questi due piani, sempre solidali (un’espressione è tale solo in rapporto a un certo contenuto e, allo stesso modo, un contenuto può dirsi tale solo rispetto a una certa espressione), articolano le forme della significazione, ritagliando e rendendo discreto il continuum della materia, ovvero del senso.” (Anna Maria Lorusso)